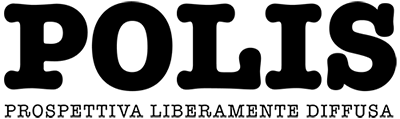L’adattamento cinematografico di un libro è sempre un passaggio traumatico, mai scevro di critiche e confronti. Profonde mutilazioni o troppa libertà interpretativa, mai che si giunga alla giusta via di mezzo. Ma come possono due linguaggi artistici diversi giungere all’ideale della coincidenza?
Per quanto Carlo Lizzani, portando sugli schermi “La vita agra” di Luciano Bianciardi, con uno straordinario Ugo Tognazzi, abbia tentato di riproporre, a mio avviso riuscendoci, lo spirito dell’opera, ciò che preme è rispolverare il ricordo di uno scrittore grandissimo che però, a distanza di tempo, resta ancora poco conosciuto e pubblicizzato.
A 45 anni dalla sua morte, che ricorre in questi giorni, l’occasione è giusta per andarsi a cercare prima il libro, e successivamente per scovarsi il film facilmente reperibile su Youtube.
“La vita agra” è la storia di un infiltrato, di un intellettuale di provincia che si reca a Milano con propositi anarchico-dinamitardi (vuole far saltare il Pirellone per vendicare 43 minatori morti in un’esplosione pilotata), ma che rimane impantanato nella vita da incubo del cittadino medio metropolitano, con la frenesia che la contraddistingue, abitante anonimo di un microappartamento diviso con una folla chiassosa, spettatore involontario di un’Italia post-miracolo, contraddittoria nei suoi scontri di piazza e nel suo consumismo dilagante.
Lo sguardo del protagonista, Luciano, è dissacratorio, ironico, nei confronti di una modernità un po’ bizzarra, mossa dall’ideale del denaro, del capitalismo distillato nelle pieghe della società da mezzi di persuasione di massa sempre più efficaci. È un proletario più sarcastico che guerrafondaio, che non partecipa attivamente alle manifestazioni popolari, che si ribella a un lavoro parcellizzato e disumanizzante, ma che l’amore per Anna e il bisogno piegheranno alla vita media.
Diventerà addirittura un creativo pubblicitario, uno di quei persuasori occulti espressione più perversa di quel tipo di società che aveva tanto criticato e vilipeso.
La storia di Luciano Bianchi, alter ego dell’autore, non smette di affascinare perché descrive una condizione piuttosto comune, quella dell’intellettuale che per ragioni di sopravvivenza si trova ad un tratto della propria vita di fronte un bivio: continuare nella cieca ribellione al sistema e subirne le conseguenze o inchinarsi allo stesso, ma dissacrarlo almeno. Luciano non ha la forza necessaria a fare quel salto del fosso che lo renda non-comune e cede alla vita comoda, ordinaria e agra, della borghesia rinunciataria, apatica, irreggimentata. La sua riflessione giunge alla conclusione che si è sempre sconfitti, qualsiasi scelta si faccia, perché si combatte contro forze stritolanti verso le quali l’individuo – spolpato, ridotto a fantoccio – nella sua solitudine ha poco da fare. È un esito rassegnato, triste, ma che mai dimentica quell’ironia di fondo, quel piglio da goliardico toscanaccio che contraddistingue tutta la produzione di Bianciardi.
“Lo so, direte che questa è la storia di una nevrosi, la cartella clinica di un’ostrica malata che però non riesce nemmeno a fabbricare la perla. Direte che se finora non mi hanno mangiato le formiche, di che mi lagno, perché vado chiacchierando?
È vero, di mio ci aggiungo che questa è a dire parecchio una storia mediana e mediocre, che tutto sommato io non me la passo peggio di tanti altri che gonfiano e stanno zitti. Eppure proprio perché mediocre a me sembra che valeva la pena di raccontarla. Proprio perché questa storia è intessuta di sentimenti e di fatti già inquadrati dagli studiosi, dagli storici sociologi economisti, entro un fenomeno individuato, preciso ed etichettato. Cioè il miracolo italiano.”
Stefano Crupi
stefanocrupi@hotmail.com