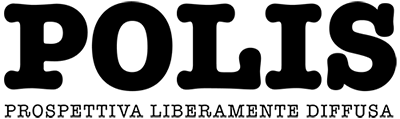“Il mare non bagna Napoli” diceva Anna Maria Ortese, per descrivere la lacerazione inflitta alla città dalla Seconda Guerra Mondiale e dall’affanno in cui versava la popolazione. Ma il mare altroché se bagna Napoli. Lo bagna in mille modi diversi, e immergersi nelle acque di questo golfo è un’esperienza non solo sensoriale, ma anche simbolica. Napoli ti risucchia; e ti mostra il fondo marino come una scoperta intima e cronologicamente infinita al tempo stesso, riservata solo a te.
Non è da molti anni, però, che io mi bagno nella mia città. Per anni ricordo che il litorale era inaccessibile ai bagnanti, o almeno io lo ritenevo tale, nonostante la sua bellezza mozzafiato. E da quando ho ricominciato a guardare non solo sopra la superficie dell’acqua, ma anche sotto, è come se avessi imparato qualcosa di più sul mio essere donna, sul mio essere napoletana, sulla mia stessa italianità. Il sale di questo mare è generoso ma non perdona; è un sale che ricorda l’appartenenza profonda di tutti noi alla nostra natura, ma anche il possibile rifiuto che ne possiamo subire se i nostri comportamenti non sono rispettosi dell’ambiente.
Per l’articolo di questo numero, visto l’avvicinarsi dell’estate, ho pensato di descrivere queste mie sensazioni per i miei amici lettori, concentrandomi in particolare su un sito di bellezza straordinaria, che va conosciuto oppure, per chi già lo conosce, ri-conosciuto come eccezionale, qualora non lo si sia fatto già.
Sin da ragazzina, la parola “Gaiola” per me non racchiudeva solo un luogo speciale, ma anche una maniera non canonica di vivere il mare. A quei tempi la situazione di questa zona era estremamente selvatica, ruspante, rocambolesca, ragion per cui veniva utilizzata solo dai giovanissimi, come luogo di mare e di aggregazione.
Solo nel 2002, infatti, viene istituita l’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”; probabilmente in quel periodo, che io ho trascorso lontano da Napoli, è cambiata l’atmosfera di questo luogo magico, che ha ottenuto un maggior ordine nella gestione come mi è capitato di riscontrare di recente andandoci fuori stagione.
Qui c’è tutto: natura, storia, arte, bellezza. Il posto prende il nome dall’isola che ne caratterizza l’immagine da cartolina: due tronconi di roccia collegati da un ponte. Probabilmente l’isolotto, raggiungibile facilmente a nuoto, era un tempo attaccato alla costa e ne fu staccato per volere di Lucullo. La storia del suo utilizzo è complessa, ma la parte che personalmente trovo più interessante risale all’inizio del diciannovesimo secolo, quando vi pose dimora un eremita, detto Lo stregone, che viveva della carità dei pescatori. In questo piccolo cammeo c’è tutto di Napoli: la miseria, la spiritualità, la superstizione, la generosità, il mistero, la natura nuda e cruda e il mare che entra nelle vite e le travolge.
Tuttavia, l’evento che ha segnato il luogo è tangibile: la costruzione nel 1874 della villa ancora oggi presente sull’isola che la rende oltremodo suggestiva. Dal 2009 il luogo è di proprietà della Soprintendenza Archeologica (Ente gestore del Parco Sommerso di Gaiola). Ci sarebbe ancora molto da scoprire in termini storici e naturalistici, com’è possibile riscontrare personalmente recandosi sul posto.
L’isola dunque è lì che vi aspetta: vi invito a superare la naturale diffidenza napoletana verso questo luogo, noto per le tante uccisioni drammatiche o misteriose degli abitanti che si sono succedute negli anni, e vivere una o più giornate godendo il mare da un’altra prospettiva: quella non solo della bellezza straordinaria, ma anche del mistero, della complessità della nostra storia e delle nostre radici.
Francesca Gerla
fra.gerla@libero.it