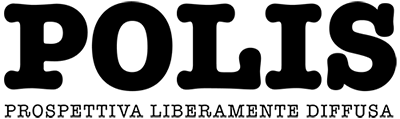Come molti sapranno, a partire dalle scoperte di Sigmund Freud sull’inconscio, si è avuta una diversa percezione del mondo, e per quanto concerne la scrittura non è stato differente. Sebbene il padre della psicanalisi non fosse uno scrittore, si interessò ampiamente di questo ambito applicandovi le sue teorie. Inizialmente si cercò di analizzare psicanaliticamente gli autori, al fine di rinvenire eventuali traumi psicologici alla base della loro attività creativa, successivamente si iniziarono a cercare, invece, dettagli nei loro testi nell’intento di captare qualche segno di pulsioni inconsce. Freud riteneva che la fantasticheria fosse una creatività condivisa dai poeti e dai bambini; beninteso però, non si trattava di follia, eventualmente geniale, bensì di una maggiore capacità del poeta di percepire l’inconscio. Ma cosa si intende con questa parola? In sostanza si parla di una realtà altra, frutto di avvenimenti del passato che rimangono latenti senza emergere in superfice. Ne è un esempio il Vitangelo Moscarda di ‘Uno, nessuno, centomila’ di Luigi Pirandello. La moglie, una mattina, gli fa notare un’imperfezione del naso, e lui è costretto a rimettere in discussione tutto. Quel dettaglio insulso viene chiamato ‘fisicizzazione dell’oltre’, ciò che fa apparire la realtà, la polvere sotto il tappeto che si è nascosta per aderire al mondo delle convenzioni sociali. Se ne trae, o meglio Pirandello ne trae, che la società crea alienazione, crea il discioglimento dell’individuo in un mare senza forma. Questa tendenza di far emergere l’inconscio, in letteratura, è tipicamente postfreudiano e segue un filone consistente nella prima metà del Novecento. Federigo Tozzi, ad esempio, racconta la storia dei fratelli Gambi; tre fratelli che nutrono un odio profondo nei confronti del padre perché questi non tiene ad altro che alla sua libreria antiquaria. Quando il padre muore, i fratelli ereditano la gestione dell’azienda paterna, una fiorente attività, che però mandano in bancarotta in poco tempo, dilapidando tutti gli averi correlati a essa. Se questo avvenimento non si spiega sul piano razionale, dacché non c’era motivo, a scanso di una cattiva gestione, che i tre fratelli mandassero in rovina una fortuna, applicando le teorie di Freud si capisce che è stata la chiusura di una gestalt, ossia di una situazione lasciata in sospeso. Distruggendo l’azienda del padre è come se avessero inferto la morte direttamente al genitore. Giacomo Debenedetti, importante critico del Novecento, chiama quest’emersione dell’inconscio, questa fisicizzazione dell’oltre, ‘Invasione dei brutti’. Le teorie di Freud, tuttavia, non vennero grandemente messe in campo da questi stesso, furono infatti i suoi allievi ad azzardare gli sperimentalismi più interessanti. Tra questi, nel tentativo di far aderire la psicanalisi ai testi degli autori, si ha quello di Marie Bonaparte, che analizzò i racconti di Edgar Allan Poe rilevando che, a causa dei contenuti fortemente macabri, lo scrittore doveva possedere una personalità incestuosa e necrofila; va da sé che, applicato in questo modo, il metodo psicanalitico poteva risultare assai troppo semplicistico e rischiare così di perdere la sua credibilità. Francesco Orlando, invece, formulò una teoria del ‘compromesso’; egli sosteneva che i testi degli autori fossero un compromesso per far emergere il ‘represso’. Numerose altre applicazioni furono tentate e, in questo contesto, non si può che accennare a qualcuna di esse celermente: si ricorda la ‘teoria degli archetipi’ di Carl Gustav Jung, che si proponeva di rinvenire delle immagini o dei simboli comuni a una società e che sarebbero alla base della sua conoscenza. Ad esempio, la ‘guerra’ rappresenta un’immagine dalla diversa interpretazione a seconda della società mentre, parlando di ‘amore’, ci riferisce a un canone più generico e universalmente interpretabile. Otto Rank tentò invece di applicare la psicanalisi ai personaggi delle opere letterarie, come il famoso Edipo re di Sofocle, che dà appunto il nome al noto complesso. Ecco, è importante riconoscere che il metodo psicanalitico, sebbene imperfetto, ha rappresentato un filone critico importante tra la fine dell’Ottocento e tutto il Novecento e ancora oggi è oggetto di studio. L’accostamento della letteratura con le scienze cognitive ha infatti colto numerose verità, specialmente riguardo all’inconscio; è certo che per l’analisi di un’opera bisogna tener conto del testo in sé e del contesto in cui è stato creato, compreso il ruolo dell’autore.
Nicola Di Nardo
nicoladinardo92@gmail.com